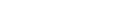Publichiamo qui di seguito il discorso pronunciato dal sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri per il 77° anniversario della Liberazione.
Al termine della cerimonia il primo cittadino ha avuto l’amara sorpresa di scoprire che la sua automobile, parcheggiata in piazzetta Sant’Ilario, dietro al Comune, era stata daneggiata da ingnoti. Il fanale posteriore era stato spaccato probabilmente con una martellata. L’avvocato Barbieri ha sporto denuncia.
«Ovunque volgiamo lo sguardo, in questa piazza che ritrova la sua festante partecipazione dopo gli anni drammatici della condivisione negata dall’emergenza sanitaria, ritroviamo i segni di quell’eredità civile e morale, di quel patrimonio inestimabile di principi e ideali per cui le donne, gli uomini, le ragazze e i ragazzi che oggi, con profondo cordoglio ricordiamo, non esitarono a dare la vita.
Nel nostro Tricolore simbolo di unità e democrazia, nell’abbraccio di istituzioni, associazioni e cittadini, nella presenza di tante famiglie che hanno voluto, in questa ricorrenza, spiegare ai figli perché la libertà conquistata dai nostri padri vada curata, onorata e celebrata, in ognuna di queste istantanee, risiede il significato più autentico della Festa della Liberazione.
Una memoria scolpita nel profilo dei monumenti, incisa nel marmo delle lapidi, modellata sulle pietre dei cippi che rendono omaggio ai Caduti per la Resistenza, il cui generoso e dolente sacrificio – valso, alla nostra città, quella Medaglia d’oro al Valor Militare di cui sentiamo vivo e forte l’orgoglio – ci insegna ancora oggi cosa siano il senso di appartenenza, il perseguimento del bene comune, il mutuo riconoscersi e credere in un’identità collettiva, l’etica della responsabilità, la coerenza nel difendere le proprie idee, il coraggio di ribellarsi alle ingiustizie, all’oppressione e alla violenza.
Furono queste convinzioni a muovere e ispirare – nelle città e nelle colline, tra i boschi e i sentieri impervi di montagna – le scelte e le azioni dei nostri partigiani e di chi, dalle più diverse provenienze di pensiero, culturali e sociali – dagli operai ai contadini, da chi vestiva l’abito talare o la divisa, dagli avvocati ai medici, dagli intellettuali agli studenti, si trovò unito nella non indifferenza alle aberrazioni del regime, alla brutalità delle sopraffazioni, alla privazione e alla perdita dei diritti delle persone.
Come ebbe a sottolineare, un anno fa, il presidente Mattarella, dopo l’8 settembre ’43 e l’occupazione tedesca, “migliaia e migliaia di italiani, militari e civili, compresero che la Patria in cui voler vivere, per la quale si poteva anche morire, non poteva che essere una Patria libera, democratica, fondata sul diritto, sulla pace, sulla convivenza. Fu una spinta ideale e morale, prima ancora che ideologica o politica…”.
E’ in nome di quel patrimonio conquistato che, in questo nostro tempo che ci costringe a confrontarci ancora una volta con l’orrore della guerra alle porte di un’Europa unita, fondata sulla cooperazione e sul dialogo tra i popoli, non possiamo essere indifferenti alle richieste di aiuto, di protezione e di tutela dell’umanità, di comune impegno nel tessere ogni filo che possa ricostruire la pace.
Come ci ricorda Liliana Segre la storia «mostra che la pace non si ottiene restando indifferenti o attraverso progressivi cedimenti agli aggressori, ma garantendo una convivenza tra i Paesi basata sul diritto e sul rispetto».
E’ un impegno a cui non possiamo venire meno: ce lo chiedono i profughi costretti ad abbandonare le loro case, i loro affetti. I bambini venuti alla luce negli scantinati e nei tunnel della metropolitana di Kyev. Così come fanno appello, alle nostre coscienze, i simboli muti ed eloquenti della devastazione: i palazzi sventrati di Mariupol, le valigie abbandonate sotto i colpi di mortaio, intorno solo corpi inermi avvolti da un lenzuolo bianco.
E allora Buon 25 aprile, Piacenza.
Per tutte le vittime del nazifascismo, per i tuoi 1500 Caduti piacentini – oltre 600 tra i combattenti, 800 i civili – lungo il cammino della Liberazione. Per tutti coloro che vennero deportati per motivi religiosi o politici, per i 6000 Internati militari e le centinaia di prigionieri civili tradotti nei campi di lavoro in Germania. Per gli oltre 1200 detenuti nelle nostre carceri tra il novembre 1944 e il marzo 1945, alcuni scomparsi senza lasciare traccia, presumibilmente uccisi e gettati nel Po, altri – la maggior parte – condannati a morte e giustiziati senza pietà, senza appello.
Anche noi, come scelsero di fare le generazioni cui oggi sentiamo di dovere tutto, non possiamo distogliere lo sguardo. Raccomandava ai suoi figli il partigiano Pietro Benedetti, in una lettera scritta pochi giorni prima di essere fucilato sugli spalti di Forte Bravetta, a Roma, nell’aprile del 1944: “Dell’amore per l’umanità fate una religione e siate sempre solleciti verso il bisogno e le sofferenze dei vostri simili. Amate la madrepatria, ma ricordate che la patria vera è il mondo, e ovunque vi sono vostri simili, quelli sono i vostri fratelli”.
Questo è uno degli insegnamenti più preziosi che la Resistenza italiana ci ha consegnato. Saper accantonare gli individualismi, le differenze, le contrapposizioni politiche, culturali e religiose, sentendosi parte integrante, facendosi carico e assumendosi, in prima persona, la responsabilità di un bene più grande e universale.
Nella sua “Lettera a un partigiano”, don Primo Mazzolari ricordava: “La brigata portava un nome e un’insegna di partito, ma niente ti prendeva di quel particolare. Tu eri partigiano della libertà di tutti, lottavi e soffrivi per tutti gli italiani”. Grazie al cammino della Liberazione, ammoniva, si era compiuto il passaggio da una politica che temeva e per questo soffocava ogni autonomia di pensiero, alla democrazia che ha bisogno “non di comparse, ma dell’uomo. Perché le comparse si nutrono del peggio, mentre l’uomo osa chiedere un po’ di pane, un po’ di giustizia, un po’ di libertà per tutti”.
A 77 anni di distanza dagli eventi che oggi commemoriamo, sta a noi ritrovare e sentire nostra quella stessa fierezza, quegli stessi occhi limpidi e consapevoli, quella solidarietà umana che indusse così tante famiglie, allora, a rischiare la propria incolumità e tutto ciò che possedevano per ospitare, rifocillare e nascondere i partigiani e i soldati alleati. Nei casolari di campagna, nelle dimore contadine, furono innanzitutto le donne – il cui ruolo fu spesso in prima linea non solo come staffette e infermiere, ma anche nell’imbracciare le armi – ad assicurare accoglienza e protezione alle minoranze perseguitate, trasformando quelle stanze ora in quartier generale, ora in centro di distribuzione della stampa clandestina o depositi di munizioni, sfamando i fuggitivi, fornendo loro abiti civili, prestando cure e assistenza.
Offrire una speranza di salvezza voleva dire esporsi all’eventualità dell’arresto, della tortura, della morte. A pagare con la deportazione furono, per il loro attivismo nel supportare i ribelli e favorire la fuga dei prigionieri militari stranieri, Francesco Baio e il figlio Cesare, che spirò nel campo di concentramento di Colonia tra le braccia del papà, senza poter mai leggere la lettera che la mamma Maria, anch’ella arrestata, aveva spedito loro.
Ma nessuno si tirò indietro, in nome della pace e di quella spasmodica ricerca della libertà a cui oggi torniamo a rendere il nostro tributo.
E allora, di nuovo, buon 25 aprile, Piacenza. Viva l’Italia libera e democratica, che crede nella pace e difende sempre i diritti dell’umanità».